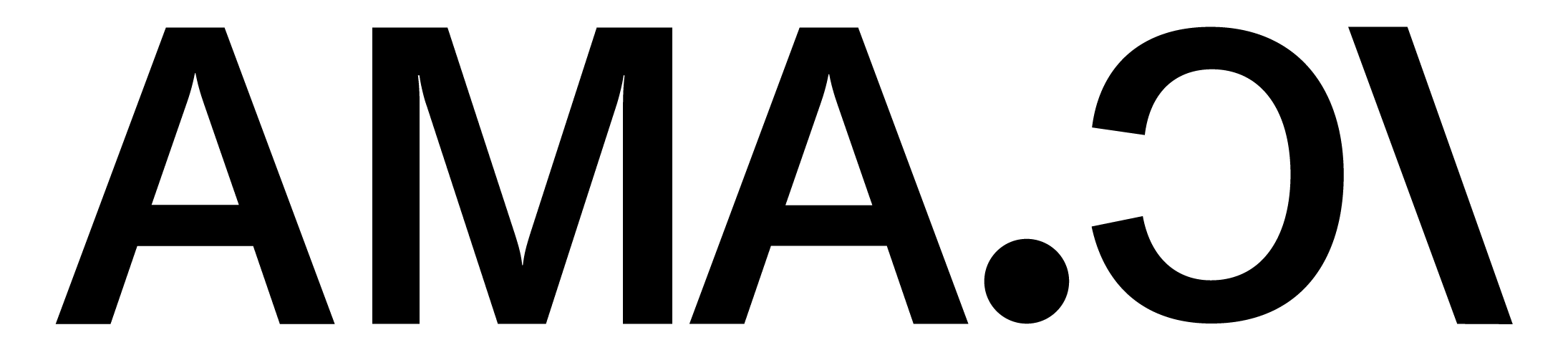Nell’arte… la via ossimorica di Paolo Pennisi
Sul destino di una vera e propria contraddizione estetica
di Massimo Donà
“Io non mi voglio innamorare dell’oggetto, perché odio l’artista che riproduce sempre la
stessa cosa…. Io accetto il concetto del tutto e il contrario di tutto… come cercare la pietra
filosofale. Anche perché non credo che ci sia un piacere finale”
Paolo Pennisi
Un artista impegnato, Paolo Pennisi. Di sicuro lo è stato. E’ stato anche questo. Una persona
sempre attenta a quanto la storia (da quella universale dominata delle grandi svolte epocali
a quella minimale, ma non meno determinante, del soggetto singolare) imponeva come
compito, come necessità. Un soggetto attento a decifrare e smascherare le forme della coercizione,
del potere e della perversione – cui l’essere umano sembra esser da sempre in qualche
modo destinato. La sua è stata sicuramente l’ossessiva ricerca di una dimensione umana
‘dignitosa’, che proprio l’artista avrebbe dovuto contribuire a costruire – e a progettare come
sempre ancora possibile (pur nel suo dimostrarsi effettualmente irrealizzabile). Come una
vera e propria rigenerazione esistenziale. Un’arte utile si proponeva e ricercava instancabile
Pennisi; avvertendone intensamente la mancanza.
Ma egli era nello stesso tempo perfettamente consapevole del fatto che il meccanismo
della conoscenza -quello stesso che non può non imporre, al vero artista, una radicale
riflessione sulle ragioni del proprio incessante fare creativo- è tale da costringerlo ad attendere
dagli ‘altri’ la risposta alle proprie ossessive domande, alle proprie inestirpabili inquietudini.
Egli sapeva bene, infatti, che l’artista non può e non deve inventare qualcosa da proporre
all’altrui attenzione; perché l’artista nega ogni forma ed espressione del ‘potere’. E si dispone
all’ascolto, attendendo che una ragione per continuare gli venga donata, come a chiedergli
aiuto… per poter così venire finalmente alla luce. Quasi reclamando il suo soccorso.
Perciò la conoscenza che comunque egli cerca e vorrebbe ogni volta guadagnare è destinata
a comporsi in una comunicazione che va a sua volta intesa come rapporto di perfetta reciprocità
(scevra cioè da vani sentimentalismi o vuote risonanze di un troppo generico dolore
del mondo).
Egli sapeva bene, in questo senso, che l’equilibrio e il distacco sono essenziali -l’angoscia e
l’urlo competono infatti alla grigia normalità, alla più insignificante quotidianità. Quella che
i mass-media ci scaraventano addosso giorno dopo giorno- e che ci si offre impudica ai
bordi della strada, appena fuori dalla porta di casa.
L’artista invece non può che elevarsi dalla mediocrità del dolore (già qualcuno aveva parlato
di “banalità del male”).
Di tutto ciò Pennisi era assolutamente convinto; proprio di questo parlava nel 1988 in un’aula dell’Università di Venezia, su cortese invito di Giuseppe Mazzariol.
Se il “conoscere” implica sempre un atto di violenza, di sopraffazione, allora la sua attenzione, il suo farsi amico della malattia (di quel male del mondo che l’arte avrebbe avuto pur sempre il compito di debellare -… necessaria ou-topìa di ogni forma del fare artistico), sembrava quasi profilare il bisogno
di una sorta di espiazione. Quasi un senso di colpa traspare infatti dal suo rigore
intellettuale, tenuto ben saldo anche nei momenti di maggior concitazione ideologico- rivoluzionaria.
Rigore intellettuale e passione politica, dunque – quasi un ossimoro. Che Pennisi teneva sempre vivo. Ben lontano dal volerlo risolvere nella quiete di un improbabile e semplice “Manifesto”, magari sfacciatamente ideologico (come quelli così familiari a tanta arte del dopoguerra italiano), egli lo vivificava; e lo alimentava in continuazione. Perciò avrebbe potuto concedersi all’infinita ripetizione
dell’immagine -“quel formarsi delle immagini si ripete in ogni istante, in ogni singolo”, annotava nel 1992. Quasi a voler dar voce all’impossibile- all’accadimento di qualcosa che non ha immagini, che nessuno ha visto, e che pur resta nell’animo a testimoniare che qualcosa è comunque accaduto…
lo stesso di sempre, quello che in ogni evento in qualche modo significativo, forse, si lascia percepire, accogliere e manipolare. Ma il segno che ne rende testimonianza deve rompere l’ordine logico della successione e dello svolgimento progressivo -ossia, deve ripetersi insensato e spaesante, inquietante
come la passione che sempre ci muove e commuove di là da qualsivoglia ragione. Anche se, già in tale ripetersi, in tale prender corpo, esso si fa trasfigurare e si trasforma in istanza e forza creativa che tende al divino, e quindi alla perfezione della definitiva misurabilità. Al sempre ri-conoscibile, anche se
mai davvero conosciuto. Come la nostra eterna solitudine: unica verità da capire, per Pennisi. Quella che gli umani e le loro azioni sempre polverizzano; così come polverizzano le proprie inquietudini, dotandole di senso, di ragioni e di cause legittimanti. Rendendole per ciò stesso redimibili, superabili-
le medesime che solo l’artista, forse, può riconoscere in tutta onestà (forse perché sa quel che fa ?) di non riuscire a possedere. Certo, le sente, le vede, sa che ci sono… ma sempre riconosce lucido, nello
stesso tempo, la propria perfetta impotenza. Conosce dunque le proprie utopie, le sente familiari -sa infatti che il “potere” non si abbatte, che l’impotenza è il nostro universale destino. Ma non smette per ciò stesso di combattere- come in una catena umana di leopardiana memoria. Egli conosce bene la
solitudine dello stesso male, del dolore – e quindi del “potere”. Sa infatti che anche il potere è solo ‘se stesso’; che esso è sempre tale proprio nel riprodursi sempre uguale, in modo perfettamente logico, da parte dei suoi segni. Sa dunque che esso è davvero sempre identico a sé nulla riuscendo invero ad afferrare della vita reale, degli infiniti tormenti e delle infinite gioie di cui quest’ultima è sempre costellata. D’altro canto, annullare una forza antagonista -rilevava Pennisi in un testo del 1987-
non può che far ingoiare i suoi resti, che rigenerano vecchi tabù, leggi eguali, ordinamenti- regole-dogmi, nel trionfo dell’assurdo e del paradossale. Certo, egli si rifiutava di estraniarsi dalla società in cui il caso lo aveva collocato; eppure, ogni volta, ineludibile, riemergeva la sua più propria ‘identità’; e con essa riemergevano progetti impotenti, risoltisi in immagini sempre uguali, anche se sempre travestite, e dunque solo apparentemente diverse. Lo riconosceva con grande lucidità in un testo del 1984, scritto in occasione di una mostra nella Galleria “Il Traghetto” di Venezia. In Pennisi, insomma, riluceva al massimo grado il paradosso proprio di ogni vera espressione artistica – sempre onnipotente
nelle intenzioni e nella fiducia (da cui, solamente, avrebbe potuto originarsi), e nello stesso tempo perfettamente impotente nei risultati, nella loro ‘bella’, ma beffarda oggettualità… senza senso; come il “cra” della rana che chiama dal pantano, nel quadro mai dipinto “un giorno di agosto, forse il 25”.
L’esperienza di Paolo Pennisi, dunque, può davvero servire di monito ancor oggi; di sicuro a chiunque dell’arte non sia disposto a fare mera decorazione (la medesima in cui il nostro vedeva essersi risolte anche le più urgenti istanze di tanto astrattismo e informale nella seconda metà del Novecento).
Può servire di monito a chiunque intenda, come lui, tornare a dar voce alla impotente – necessità di un gesto mai assicurato, mai effettualmente produttivo, eppur perfettamente ineludibile di quelli che solo la grande arte ha saputo ospitare nella quiete delle proprie vitali, eppur destabilizzanti, residualità
oggettuali. La cui potenza non va peraltro mai commisurata all’astratta efficacia… nulla esse potendo davvero. D’altro canto, egli lo sapeva bene: l’arte “non abbisogna né di ideali basati sulla forza e
sulla violenza né di pratiche mistificatorie di alcun tipo”. Nulla potevano, in questo senso, neppure le sue potenti inscrizioni oggettuali; potenti, appunto, ma sempre sostanzialmente fantasmagoriche – nulla potevano se non riconoscere “la propria natura elementare e proprio per ciò farsi capaci di sentieri
non univoci o preordinabili”. Solo l’efficacia pretende infatti univocità e quindi astratta determinazione. Precisione e logica consequenzialità. Il contrario, insomma, dell’eventualità assoluta costitutiva di ogni evento autenticamente artistico – imprevedibile, ogni volta, ma sempre secondo
necessità. Perché ‘libero’, ossia non vincolato a scopi od obiettivi lucidamente e razionalmente pre-figurabili… e per ciò stesso univoci. Ossia, determinanti (al modo dei giudizi conoscitivi così rigorosamente formalizzati da Kant). Libero anche di non-essere, dunque.
Ma allora, davvero, il procedere connaturato al fare artistico non è poi così diverso dagli itinerari
sempre paradossali e dunque ‘femminili’, ovvero umorali, caratterizzanti la gratuità di ogni vera esperienza amorosa. Dalle sue disjecta membra; mai ordinabili, appunto, nella forma dell’argomentazione e della dimostrazione. E dunque costitutivamente estranee al dolore, al potere e alla sofferenza sempre connesse ad ogni determinazione gerarchica e ad ogni conseguente privazione di libertà. Ma il procedere artistico non potrà e non dovrà mai significare -ci invita ancora una volta a
riconoscere Pennisi- mera fuga verso il fuoco sacro tanto caro a certo romanticismo di maniera.
Al contrario – l’esperienza dell’arte è incessante opera di conoscenza, ri-conoscimento
e classificazione, giudizio e riflessione…: da ciò un vero e proprio contraccolpo in se
stessa. Una vera e propria contraddizione.
E Pennisi, a questo proposito, non aveva davvero alcun dubbio: “la contraddizione deve
essere alla base di ogni ragionamento artistico e anche politico”.